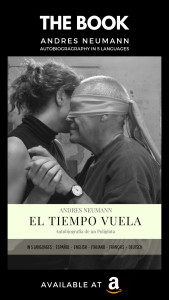IL TEMPO VOLA
Per Renè, un giorno.
Se non qui, dove?
Se non adesso, quando?
Se non io, chi?
– Hillel the Elder
.
Hotel Bolivia
Solo dopo aver superato la soglia del mezzo secolo mi è stato possibile sviluppare con un po’ di chiarezza (e soltanto grazie al mio approccio ai progressi straordinari delle discipline di autoconoscenza avvenuti all’inizio del ventunesimo secolo) alcune delle bobine di pellicola contenenti le prime impressioni sulla mia caduta sulla Terra.
Sapevo che il luogo dell’impatto si chiamava Cochabamba, e che la zona del continente sudamericano in cui si trova Cochabamba si chiamava Bolivia, ma nonostante i miei dieci anni di psicoanalisi freudiana, la maggior parte delle implicazioni di tale evento era rimasta oscura per me. Un esempio: la lingua parlata dalle persone che si vedono impresse sulla pellicola sviluppata (le stesse che formano la mia famiglia) non è la lingua usata dagli abitanti di quella regione del pianeta (gli indios), e neppure il linguaggio tramite cui comunicano coloro che vivono nel luogo dove mi trovo ora (gli italiani), mentre sto cercando di scrivere quest’autobiografia. Per tale motivo, ancora adesso, zoppico sullo stesso piede: è stato arduo decidere quale lingua usare in quest’esercitazione riepilogativa.
Ma torniamo alle bobine. Tutto faceva pensare che a sbagliare la zona dell’atterraggio non fossi stato io soltanto, ma che le stesse persone che mi avevano accolto sul pianeta si trovassero a loro volta in un posto sbagliato. Perché l’argomento di cui si parlava insistentemente nelle bobine era quello della fuga transoceanica degli ebrei (i buoni, e apparentemente io appartenevo a tale gruppo), perseguitati dai tedeschi (i cattivi, la cui lingua, inspiegabilmente, era quella parlata da coloro che mi avevano accolto).
Ho impiegato molto tempo a comprendere il vero rapporto tra tutti questi elementi: ebrei e tedeschi, indios e spagnoli, aymarà e quechua (due etnie con lingue diverse), e anche tra America Latina ed Europa, tra Cochabamba e La Paz (capitale dove trascorremmo l’ultimo periodo boliviano), tra lama ed asini, tra cani e gatti (ancora oggi mi è difficile capire come mai i gatti non siano le femmine dei cani). Forse, e anche a causa della decisione presa dalla mia famiglia, quando avevo cinque anni, di emigrare verso un altro paese «più civile» (l’equivoco sul luogo del mio atterraggio sarebbe finito in questo modo?), non ebbi il tempo né il modo di approfondire la questione.
È comunque curioso che, nel mio incessante vagabondare sulla Terra, proprio in tutte le direzioni possibili e immaginabili, io non sia mai più tornato a Cochabamba né in Bolivia. Fino a pochi anni fa nutrivo la ferma convinzione d’essere stato l’unico esemplare di una razza tricerebrale caratterizzata da uno stravagante miscuglio di culture, finché ho scoperto, in un libro intitolato Hotel Bolivia, che in realtà ero parte di una stirpe composta da migliaia di profughi, i quali si erano trovati di fronte a impressioni e sensazioni analoghe alle mie.
Ciò che invece non sono riuscito mai a capire è il motivo per cui sei milioni di esseri umani non compresero in tempo (come invece aveva fatto la mia famiglia) che bisognava assolutamente fuggire se non si voleva finire sterminati.
.
Come l’Uruguay mai
Trascorsi un breve periodo a Buenos Aires, durante il quale ebbi una sorta d’iniziazione sessuale grazie al mio incontro con la figlia adolescente del padrone dell’albergo che ci ospitava, che m’invitò a mettere una mano tra le sue cosce, e per me l’emozione fu tale da provocarmi una febbre improvvisa.
L’episodio si riprodusse, in direzione opposta, quando le mani dei miei genitori s’intrufolarono tra le mie gambe allo scopo d’introdurmi nel corpo una supposta, procedimento svoltosi in presenza della stessa ragazzina. In seguito, con papà Kurt, mamma Paula, la nonna Oma e gli zii Erich ed Edith, sbarcammo a Montevideo, dopo un lungo viaggio notturno lungo il Rio de la Plata, sul battello della Carrera. I risparmi dei miei genitori erano stati bruciati da un’improvvisa inflazione che aveva travolto l’economia argentina, e mio padre, che doveva cercarsi un lavoro, mi portava tutti i giorni a passeggio nel parco degli Alleati, parlandomi di vari argomenti della vita: tutti discorsi che mi segnarono molto in profondità.
Alla scuola “Cervantes” di Montevideo non avevano mai visto arrivare un ragazzino di sette anni che non sapeva neanche una parola di spagnolo. Furono chiamate la direttrice e altri insegnanti a osservare tale fenomeno, e da allora in poi, cioè durante l’intero percorso delle elementari, venni trattato in modo speciale, ovviamente con mia grande gioia. La mia sola amica, in classe e a scuola, era Doris Hajer. Giocavo spesso con lei al Parco Rodò, mentre le nostre mamme chiacchieravano accomodate su una panchina. Miracolosamente anche lei, figlia di immigrati, parlava tedesco come me. Non riuscii mai a convincerla dell’unica cosa che m’interessasse in quel momento: legarla al tronco di un albero.
Mi appiccicai a Doris come un francobollo per vari anni. Anziché legarla all’albero la legai a me, il che, per mia fortuna, non le spiaceva affatto. Tuttavia scoprii in lei una cosa che produsse in me quasi uno shock: Doris, passando davanti a una chiesa, si faceva il segno della croce. Com’era possibile? Dunque era una nemica? Infatti, secondo quanto mi avevano riferito, i soli tedeschi buoni erano ebrei, mentre i cattolici erano tutti cattivi. E allora lei da parte stava? Le cose presero a complicarsi. E fino a che punto lo avrei capito solo parecchi anni più tardi, dopo due matrimoni e vari rapporti sentimentali importanti con donne cattoliche.
Quegli anni furono fondamentali per la formazione e il consolidamento di alcuni aspetti del mio carattere. I miei maestri furono Karl May, Walt Disney, la ‘Sittengeschichte’ di Ernst Fuchs e il fenomeno dei dischi volanti. Karl May è uno scrittore tedesco di libri per ragazzi che racconta storie del Far West e altre del Far East, che mi furono di grande aiuto per comprendere la complessità delle relazioni tra esseri umani, indios e bianchi, arabi ed europei. I tre cavalieri e Saludos amigos di Disney, nel parlare del lago Titicaca e dei lama, dei gauchos, boleadoras e horneros (uccelli tipici dell’Uruguay), davano visibilità e legittimità alle mie esperienze così come al continente dove mi era toccato vivere, riuscendo per la prima volta a contrastare la sgradevole sensazione d’irrealtà che continuava a suscitare in me tutto ciò che riguardava l’America Latina, mentre con i miei genitori tenevamo lo sguardo fisso sugli Stati Uniti e l’Europa (dove si trovava – mi dicevano – «la famiglia»).
La Sittengeschichte è un malloppo di tre volumi che illustra, con immagini raffinate, le usanze erotiche europee nei secoli, visioni che mi procuravano le prime inquietudini sessuali, insieme a Minny di Walt Disney che rischiava di morire legata a un albero, mentre avanzava verso di lei una sega elettrica, e alla riproduzione di una Deposizione di Cristo, con accanto la Madonna in lacrime. Ma negli ultimi anni delle elementari, il mio più autentico interesse fu lo studio del fenomeno dei dischi volanti (OVNI, ovvero «oggetti volanti non identificati», secondo la definizione tecnica), per cui avevo organizzato, col permesso e l’aiuto di maestri e allievi, un comitato di ricerca che si riuniva a scuola due volte a settimana.
.
L’indio papimami
Bastò un trasloco dal Centro a Carrasco, elegante quartiere residenziale di Montevideo immerso in una natura densa e malinconica, a diciotto chilometri ad Est sulla costa, perché tutti i convincimenti che avevo raggiunto con fatica si disintegrassero in modo irrimediabile. Come la certezza di saper nuotare. I miei genitori mi avevano sempre detto che sapevo farlo alla perfezione, e io avevo dato più credito a loro che alla sperimentazione. Pur vivendo in una città di mare, l’acqua mi faceva paura.
Doris era rimasta indietro, la nostra casa era più vuota di prima (gli zii e la nonna non erano venuti con noi) e alle scuole medie di Montevideo non avrei trovato nessuno degli amici delle elementari. Nel nuovo quartiere trovai invece dei ragazzi che sarebbero divenuti il mio universo nella mappa immediatamente successiva della mia vita. Il primo impatto con loro fu piuttosto duro: mi appiccicarono addosso il nomignolo di «indio papimami» perché venivo dalla Bolivia ed ero sempre attaccato alle gonnelle di mami o ai pantaloni di papi (li chiamavo così).
Ma il tempo, la quantità e la varietà umana del gruppo (la numerosa famiglia Reches, le sorelle Domínguez, le Cohrs coi loro cavalli) mi offrirono la possibilità d’identificare i compagni d’avventura dei quali avevo bisogno. Acquistò per me un particolare rilievo un’attraente e stravagante famiglia italiana (i Poggio-Gnecchi di Milano), con tre maschi della mia età: in pratica mi adottarono, trasmettendomi un modello di vita fatto di gusti, sapori e interessi (non ultimo quello per Ratòn Mickey, che in italiano è Topolino) che avrebbero influito in modo determinante sulla mia decisione di andare a vivere in Italia, presa molto tempo dopo e in circostanze ben diverse.
Gli eventi che segnarono quella tappa furono: il tradimento di mia madre, la quale aderì senza alcuna resistenza alla decisione paterna per cui io ero cresciuto troppo per ricevere ancora gli sbaciucchiamenti materni; la risoluzione che ne derivò di andarmene via di casa, prendendo alloggio in una dépendence in giardino; la mia passione per il jazz e il ping-pong; i turbamenti provocati dalle sinuosità delle portegne ‘Ragazze di Divito’, raffigurate sulla rivista comica Rico Tipo, e le curve delle focose mulatte della rivista cubana Bohemia; l’autonomia che mi dava la bicicletta; i balli check to check sulle note di Only you dei Platters e le frenetiche contorsioni del rock-and-roll di Bill Halley; la scoperta del mondo dei cani e dei cavalli; le misteriose costruzioni esoteriche dell’ingegner Pittamiglio; l’inquietante lettura di autori quali Curzio Malaparte e Jean Paul Sartre; i viaggi negli States, in Europa e in Israele con i miei per conoscere «la famiglia»; il crollo definitivo delle mie speranze di diventare «ingegnere come papà», avvenuto quando mi trovai a scontrarmi col muro della matematica; il conseguente abbandono degli studi e l’inserimento precoce nella vita lavorativa attraverso l’assunzione nella ditta d’impianti elettrici Rodríguez y Neumann S.A; e l’assassinio di John F. Kennedy.
.
La Francia e il Teatro
Due tra i fratelli di mia madre (erano nove), Josef in Israele e Salo a New York, lasciarono in me un ricordo intenso e duraturo. Il primo soprattutto, artista e guida turistica, che aveva combattuto nell’esercito inglese al servizio del famoso generale Montgomery, contro Rommel e l‘esercito di Hitler nell’Africa del Nord, mi aiutò a capire da dove provenivano tante delle mie domande.
Questo, in realtà, successe molti anni dopo, quando conobbi pure sua figlia Maly a Gerusalemme e mio cugino Friedman a Tel Aviv (scienziato e cabalista, allievo del premio Nobel belga Prigogyne). Risale a quegli anni anche la mia passione per il cinema. Allo scadere del diciottesimo anno di età m’iscrissi al Cineclub di Montevideo, e lì m’innamorai della segretaria, che sarebbe diventata in seguito mia cognata. Il che accadde quando m’innamorai (molto di più) di sua sorella Lily Salvo, madre di mia figlia Mara. Durante quel periodo Ingmar Bergman, il neorealismo italiano, Orson Wells, Kurosawa, l’espressionismo tedesco, Antonioni, Fellini e la Nouvelle Vague francese – in lingua originale, con sottotitoli – diventarono una guida importante nel viaggio labirintico della mia vita.
Il mio amico Marco era andato a studiare alla Columbia University di New York; avrei voluto seguirlo ma, a quanto pare, il mio desiderio non fu abbastanza forte da superare l’opposizione dei miei genitori, che avrei apprezzato in seguito, quando sarebbe arrivata la notizia del suicidio di Marco. Sorte condivisa tempo dopo da Susana Domínguez, fidanzatina che avevo abbandonato nel quartiere, e che si era sposata con il mio amico Jean Paul Brisson trasferendosi a Parigi.
All’epoca, in Uruguay, fare cinema sembrava un’impresa impossibile. L’ambiente più accessibile era il teatro, nel quale immaginavo di poter trovare ragazze belle e disponibili. In quel momento ero ben lontano dall’immaginare che il teatro sarebbe divenuto il mio lavoro. Mi ero fidanzato con Bettina Camacho, ragazza quindicenne (che sposai poco dopo), allieva del Liceo Francese (compagna di classe di Perla Domínguez, del nostro quartiere) e attrice in un gruppo amatoriale dell’Alliance Française. Andavo a prenderla tutti i giorni alle prove e l’aspettavo seduto in platea; un giorno Bernard Schnerb (diventato presto mio amico, maestro e mentore) mi disse: «Perché non vieni a darci una mano?».
Subito dopo mi affidò un registratore per la messa a punto di alcuni effetti sonori necessari allo spettacolo: lo scricchiolio di una porta, tuoni in lontananza, il latrato di un cane… Fu il primo passo lungo il cammino che mi ha portato dove sono oggi. Divenni presto il migliore tecnico del suono per il teatro e la danza di tutto l’Uruguay, vincendo alcuni dei premi assegnati ogni anno dai critici teatrali nel sontuoso Teatro Solís di Montevideo. Di giorno lavoravo nella ditta d’impianti elettrici della mia famiglia («in futuro sarà tua», mi dicevano), e la sera ero impegnato nei teatri cittadini «per amore dell’arte».
Paradossalmente il teatro, a quel tempo, era sia professionale che amatoriale, visto che l’intero ricavo della vendita dei biglietti, eccetto quelli della Comedia Nacional, era destinato all’organizzazione della macchina teatrale, e non restava niente per gli stipendi o i compensi ad artisti e tecnici. Avevo inoltre il grande privilegio di poter andare ogni anno in Europa e negli Stati Uniti in modo da soddisfare la mia curiosità culturale insaziabile, ampliare i miei orizzonti e vedere quanto di nuovo si produceva in campo artistico.
Da tutto ciò prese forma un altro segmento fondamentale della mia personalità: portavo dai viaggi materiale sonoro, letterario e visivo per poterlo condividere coi miei compagni di Montevideo. Fu tutto questo che, insieme alla mia padronanza delle lingue, mi avrebbe aiutato molto, qualche anno dopo, a inventare la professione di agente teatrale, creando l’agenzia Andres Neumann International a Firenze.
La mia piattaforma di lancio fu l’Alliance Française, con la sua nuova sede, la meravigliosa biblioteca e il suo moderno teatro di duecento posti, alla costruzione del quale diedi il mio contributo. In seguito lo avrei diretto per vari anni, insieme a Bernard Schnerb. Avevo diverse vite parallele e spesso in conflitto tra loro. Da una parte vivevo nella comunità francese nella quale mi ero completamente integrato (parlavo il francese che avevo imparato molto presto e in modo spontaneo, a differenza dall’inglese, che mi costò vari anni di studio in un scuola di lingue).
Dall’altra avevo il ruolo di rappresentante ufficiale di mio padre nelle riunioni del consiglio d’amministrazione del Banco de Trabajo Italo-latino-americano diretto da un ex ministro di economia di Mussolini, il professor Domenico Pellegrini-Giampietro. Nel 1967 dovetti occuparmi di tutti gli allestimenti relativi all’incontro internazionale, a Punta Este, dell’Organizzazione degli Stati Americani, presieduta per l’occasione niente meno che dal presidente degli Stati Uniti Lindon Johnson: mi capitò di stringergli la mano, e ricordo che ne ricavai l’impressione di aver toccato la pelle di un elefante.
Ma il contrasto più stridente nel mio vissuto erano le mie attività attorno alle avanguardie artistiche, con l’organizzazione e la partecipazione a concerti di musica elettronica, happening ed eventi fluxus, con Conrado Silva e José Gabay, concerti beat nel Teatro Solís con testi di Boris Vian e Leautreamont, programmi trasgressivi nel Juan Sebastian Bar, locale notturno molto di moda a Punta Este, e soprattutto l’allestimento di installazioni modernissime di multivisione realizzato con architetti e scenografi quali Jorge Carrozzino e Carmen Prieto.
Erano gli anni sconvolgenti e rivoluzionari del maggio ’68 a Parigi, ai quali mi adeguai a modo mio, legandomi sentimentalmente a Lily Salvo, sposata e con due figli, Aldo e Bruno. Lily era nota negli ambienti intellettuali ed artistici dei circoli montevideiani come “la divina”: pittrice famosa, era stata allieva di Torres García e amica di Pablo Neruda ed Ernesto Sabato. Aveva quarant’anni ed io venticinque, particolare che accentuò notevolmente lo scandalo suscitato dalla nostra relazione, e che la portò ad abbandonare la sua famiglia per poter vivere in libertà il nostro rapporto.
Da quel momento prese il via un periodo molto agitato, durante il quale cercavo di mantenere la moglie bambina mentre vivevo la relazione con la pittrice-dea, in un groviglio di bugie che crollò implacabilmente il giorno in cui trovai le due donne sedute insieme a casa mia in salotto, a prendere il tè. In tal modo l’andirivieni si fermò, e finalmente potei andare a vivere con Marilyn Monroe (mia personale visione terrena della dea) e assaporare a fondo i piaceri del sesso e della passione, che produssero, come frutto meraviglioso, una creatura bionda alla quale avremmo dato il nome di Mara.
Ma sullo sfondo di questa storia stava avanzando una tempesta foriera di conseguenze abnormi. Mi riferisco alla comparsa dei Tupamaros, una delle prime organizzazioni del terrorismo di sinistra ispirata al Che, combattuta (o forse stimolata, cosa mai chiarita) da una repressione di destra sempre più dura, che in pochi anni avrebbe fatto precipitare il paese in una dittatura militare. Di lì a poco l’atmosfera si fece irrespirabile. Non si poteva parlare liberamente. Ovunque c’erano blocchi stradali militari. Molte delle persone che frequentavo e con le quali lavoravo erano state catturate e torturate dai militari e dalla polizia, oppure si davano alla clandestinità o fuggivano all’estero.
Alcuni, come Gaetano Pellegrini (figlio del ministro di Mussolini e collega di mio padre in banca), furono rapiti dai Tupamaros. Mi sentivo tra due fuochi. L’assassinio dell’addetto militare all’Ambasciata Americana Dan Mitrione (tema de L’Americano, splendido film di Costa Gavras interpretato da Yves Montand, capace di restituire alla perfezione il clima del momento), e la bomba che distrusse il Club del Golf di Montevideo (attentato compiuto, come si venne a sapere in seguito, da un nipote di Lily), determinarono il colpo di grazia: bisognava scappare! Stavo vivendo la stessa esperienza vissuta dai miei genitori trentacinque anni prima, ma nella direzione opposta…
.
Dalle Ande alle Alpi
Grazie ancora una volta a Bernard Schnerb, e insieme ai Carrozzino, il 4 ottobre del 1972 ci fu possibile partire per la Francia dopo un affrettato matrimonio tra me e Lily e l’iscrizione tardiva all’anagrafe di Mara, essendo entrambi ancora in attesa delle rispettive sentenze di divorzio. Avevo ricevuto una borsa di studio dal governo francese per studiare in un’istituzione della città di Nancy diretta da Jack Lang (futuro Ministro di Cultura, che in seguito mi avrebbe concesso l’onorificenza di Chevalier des Arts et des Lettres).
Sui giornali uruguaiani di destra uscirono articoli nei quali si diceva che Andres Neumann, Jorge Carrozzino e Carmen Prieto andavano in Francia grazie a fittizi programmi culturali, e che in realtà venivano addestrati a tecniche di guerriglia (va ricordato che in quel periodo, in Bolivia, c’era una forte intesa fra il noto intellettuale Regis Debray e Che Guevara). L’istituzione che ci ospitava era il CUIFERD, un centro di studi legato al Festival Mondial du Théâtre de Nancy, santuario delle avanguardie teatrali di quegli anni.
Non potevamo chiedere di meglio: era il posto giusto nel momento giusto. Però era necessario adeguarsi a una vita spartana, da studenti senza soldi, in una città di provincia al Nord Est della Francia. Eravamo partiti all’improvviso con l’intenzione di restare a Nancy per un anno ad osservare cosa succedeva in Uruguay, senza sapere che la dittatura militare sarebbe durata dodici anni. Arrivammo in inverno, e all’inizio fummo accolti dai servizi sociali nell’infermeria di una Maison des Jeunes Ouvriers.
Poi ci trasferimmo in un appartamento di quattro stanze condiviso da quattro adulti e due bambini: Mara di sei mesi e Paolo, figlio dei Carrozzino, di quattro anni. Arredammo l’appartamento con quello che ci offriva la gente e con quanto si riusciva a trovare per la strada; si mangiava al RestòUI, la mensa universitaria. Quei due anni trascorsi a Nancy furono difficili, ma fondamentali per il resto della mia vita. Le esperienze che potei vivere, le persone conosciute, il lavoro creativo col quale venni a contatto, costituirono la materia prima sulla quale avrei edificato il mio futuro.
Avere accesso al laboratorio dell’avanguardia artistica mondiale dell’epoca – mi riferisco al lavoro di Tadeusz Kantor, Pina Bausch, Peter Schuman e del Bread and Puppet, e ancora di Bob Wilson, Victor Garcia, Dario Fo, Grotowsky, Augusto Boal, Robert Anton, Luis Valdez – rappresentò per me un’opportunità straordinaria e un immenso privilegio. E collaborare con Jack Lang e con la sua équipe si sarebbe dimostrato più istruttivo e professionalizzante che seguire i corsi di qualunque università, anche della più prestigiosa.
Ma non tutto era rose e fiori. Non si poteva andare indietro, neppure per prendere una rincorsa, e non sapevamo in quale direzione orientare i nostri passi. Inoltre Lily viveva male, tormentata da forti sensi di colpa per aver abbandonato a Montevideo i due figli, e Mara era ancora molto piccola. Nel 1974, quando il Festival de Nancy mi affidò l’incarico di selezionare le compagnie teatrali italiane da invitare alla rassegna, decidemmo di trasferirci in Italia: io sarei tornato a Nancy ogni mese per fare resoconti sulle mie scoperte italiane e per continuare a percepire i soldi della borsa di studio.
.
Dalle Alpi agli Appennini
Arrivare in Italia come ‘ambasciatore’ del Festival de Nancy mi aprì tutte le porte degli ambienti teatrali e culturali. Scegliemmo Firenze perché stava al centro della penisola, era una città non grande né piccola, vi conoscevamo alcune persone tramite il Partito Comunista Uruguayo e ci sentivamo attratti dall’arte.
Quando però, dopo un anno, smisi d’essere ambasciatore delle glorie francesi e decisi di restare in Italia per mio conto, le stesse persone che fino a poco prima mi avevano cercato e lusingato, presero a guardarmi con preoccupazione e sospetto. Abitavamo da poco in un piccolo appartamento di tre stanze, in via dei Leoni, 8, dietro a Palazzo Vecchio (dove saremmo rimasti per dieci anni), e avevo aperto la casella 728 alle Poste Centrali di Firenze quando Lily, una sera, mi disse la frase che Rasputin lancia contro Ivan il Terribile nell’omonimo film di Eisenstein: «L’Europa non ti riconoscerà», dandomi un ultimatum di due anni per smentirla; dopodiché sarebbe rientrata a Montevideo portando con sé nostra figlia Mara.
La sfida che mi si lanciava veniva ad assommarsi a quella, meno esplicita ma sempre in corso, lanciatami a suo tempo da mio padre, al quale avrei dovuto dimostrare d’essere un individuo capace di vivere autonomamente, avendo scelto con indipendenza la mia strada. Il dado era stato tratto, e una serie di incontri felici mi vennero in aiuto: Luigi Nono, il famoso compositore veneziano, membro del Comitato Centrale del Partito Comunista (che avevo conosciuto a Montevideo), si dimostrò un amico e un protettore. In un breve e casuale soggiorno a Villa Rucellai a Prato, mi diede la possibilità di conoscere da vicino il grande regista Luca Ronconi e la sua équipe.
Grazie all’intervento degli amici del Partito Comunista, la Provincia di Firenze organizzò per noi una tournée per far conoscere uno degli spettacoli audiovisivi su Picasso che avevamo realizzato in Uruguay prima della nostra partenza. Al Festival di Nancy era arrivata la lettera di un gruppo teatrale fiorentino chiamato Ouroboros e diretto da un certo Pier’Alli, con sede in una sala di Palazzo Pitti, il Rondò di Bacco. Negli ambienti di sinistra che frequentavamo nessuno conosceva Pier’Alli né l’Ouroboros.
Una sera mi presentai in quella sala e mi trovai ad assistere alle prove de La morte della geometria di Giuliano Scabia, e sia il lavoro che gli attori mi parvero interessanti e accoglienti. Fu in quel momento che ebbi un’idea rivelatasi decisiva per il mio futuro: proposi a Pier’Alli di organizzare al Rondò di Bacco una stagione di teatro d’avanguardia unica in Italia, invitandovi i gruppi migliori da me frequentati a Nancy e chiedendo il finanziamento del progetto al Teatro Regionale Toscano.
Detto fatto. L’idea piacque a Roberto Toni del TRT e io mi trovai a dirigere, con fondi scarsi ma sufficienti, uno spazio con una capacità di duecento posti nel quale passarono per tre stagioni successive, e in totale esclusiva, i migliori artisti delle avanguardie mondiali: tra gli altri Tadeusz Kantor, Robert Wilson, Meredith Monk e il Bread and Puppet. Erano anni in cui, al contrario di quanto accade oggi, non circolava niente. Cominciò ad affluire pubblico da Roma e da Milano. In forma privata (trascinato dalla sua fidanzata attrice), arrivò anche Achille Occhetto, segretario del Partito Comunista Italiano. Quando a Firenze circolò la notizia, i politici presero a interessarsi alle attività del Rondò di Bacco e a discutere su una gestione condivisa fra i diversi schieramenti. Inutile dire che questo determinò una vita breve per il Rondò di Bacco.
Il tempo del mio volo al di sotto dei radar era finito. Decisi allora di seguire il saggio consiglio ricevuto da Franco Camarlinghi, Assessore alla Cultura del Comune di Firenze, il quale mi aveva suggerito di aprire un’agenzia di distribuzione di spettacoli teatrali. In effetti, dopo il successo avuto a Firenze, molti gestori dei teatri italiani si mostrarono interessati agli spettacoli da me proposti.
Fu così che nel 1978 nacque la Andres Neumann International, in via Borgo Albizi. E questa ditta, pur se in forme e in luoghi diversi, esiste ininterrottamente da trent’anni.
.
Andres Neumann International
La mia vita divenne il mio lavoro. E il mio lavoro diventò un viaggio continuo. Avevo inventato, senza accorgermene, un mestiere nuovo: il Cultural Management, qualcosa che unisce il mondo artistico a quello finanziario e politico. Oltre alle cinque lingue che parlavo ormai correttamente, avevo imparato a gestire rapporti con artisti, politici e finanzieri. Per vari anni andai a Cracovia una volta al mese, prima lavorando per Kantor e poi per Andrej Wajda, il quale realizzava, oltre ai suoi film, opere teatrali importanti.
Una volta al mese mi recavo a Parigi, dove lavoravano i miei maestri nel campo della produzione e della distribuzione di spettacoli teatrali: André Gintzburger e Fernand Lumbroso. E sempre a Parigi vivevano i miei amici Ariel Goldemberg, Patrick Sommier e Michèle Kokosowsky, oltre ad alcuni miei prestigiosi clienti: Peter Brook, la Comédie Française, Jerome Savary, Alfredo Arias e Ariane Mnouchkine.
Nelle altre due settimane di ogni mese alternavo viaggi ad Amsterdam per assistere a spettacoli nel Mickery (spazio visionario creato da Ritsaert Ten Cate), a viaggi a New York (sede delle grandi compagnie di danza contemporanea), a Caracas (dove ho lavorato per qualche edizione del Festival Internacional), a Madrid e a Barcellona, città emergenti dal buio del franchismo e pronte ad aprirsi al mondo. Andavo anche a Wuppertal per Pina Bausch, a Stoccolma per Ingmar Bergman, a Mosca per Anatoli Vassiliev e a San Pietroburgo per Lev Dodin. Viaggiavo soprattutto per assistere agli spettacoli da me organizzati, e ciò avveniva in ogni parte del pianeta.
Certi eventi potevano svolgersi nel corso della stessa settimana a Tokyo, a Los Angeles, a Lisbona, a Spoleto, a Palermo, a Buenos Aires, ad Amburgo, in Messico, a Genova, a Venezia, a Milano, a San Paolo, a Vienna e a Copenhagen. All’epoca le comunicazioni non erano come oggi: non esisteva ancora Internet e non c’erano fax né cellulari; le chiamate internazionali si facevano tramite operatori dei telefoni di Stato che spesso sapevano parlare solo nella propria lingua e passavano la comunicazione dopo varie ore; con i paesi sovietici poi, si poteva comunicare soltanto tramite un vecchio e costoso apparecchio chiamato telex, funzionante tramite nastri di carta traforati.
Nonostante tali difficoltà, dalla mia sede di Firenze (fino al 1985) e poi di Roma (fino al 2000), riuscivo a dominare una rete infinita di rapporti umani, artistici e professionali. Agli artisti internazionali che mi avevano affidato il loro lavoro si aggiunsero alcuni grandi nomi italiani: Luca Ronconi, Dario Fo, Vittorio Gassman e Marcello Mastroianni, molti dei quali conosciuti nel Teatro Tenda di Piazza Mancini a Roma, dove il manager napoletano Carlo Molfese mi aveva invitato a dirigere il Festival Internazionale di Teatro Popolare.
Durante quell’avventura potei contare su alcuni alleati importanti: l’Assessore alla Cultura del Comune di Roma Renato Nicolini, il quale mi affidò un particolare progetto di scambi internazionali teatrali e culturali per la capitale, e che fu per me un maestro prezioso per quanto riguarda l’Italia, così come Jack Lang lo fu per la Francia; e ancora Enrico Menduni, Presidente dell’Arci, e Giuseppe di Leva, che dirigeva Milano Aperta. Persone molto significative, nel mio percorso, anche da un altro punto di vista: ciascuno di loro era compagno di donne alle quali sarei stato legato da vincoli di profonda amicizia.
Mi riferisco alla romana Patrizia Sacchi, attrice stravagante il cui figlio Simone è oggi marito di mia figlia Mara, ad Anna Mariani, distinta signora dell’alta borghesia ligure che con pazienza infinita m’insegnò a parlare bene l’italiano, e a Marina Baldeschi, contessa fiorentina di gran classe che collabora con me da trent’anni. Queste tre donne, con la loro amicizia e il loro esempio, mi hanno insegnato molto di ciò che so e che sono.
Ma l’alleato più decisivo si rivelò essere mio padre Kurt: visto che non avevo intenzione di far ritorno in Uruguay, chiuse la sua ditta, quella «che un bel giorno» avrei ereditato, e si trasferì in Italia insieme a Paula, mia madre. Avrebbe lavorato con me per diciotto anni, prima a Firenze e poi a Roma, offrendomi un sostegno senza il quale la mia crescita professionale non sarebbe stata la stessa. Il suo appoggio rappresentò per me un ulteriore impegno nel progetto di non deludere le speranze che erano state riposte su di me.
.
Chi sono io?
Sono stato beat negli anni Sessanta, hippy nei Settanta e yuppie negli Ottanta. Ho vissuto da ricco quando mi andava di esserlo, e da povero quando volevo farlo. Ma chi ero? Chi era realmente colui che voleva o non voleva? Io che aspiravo a dominare il mondo, in quello stesso mondo avevo finito per perdermi. Avevo abbattuto il muro delle lingue ma avevo costruito altri muri dentro di me, e dietro ognuno di essi io ero un altro, come Zelig.
È a quel punto che è iniziato un percorso di ricerca ancora non compiuto, rimasto forse in sospeso fin dall’adolescenza. Un primo passo importante riuscii a farlo grazie a una terapia psicoanalitica (con Jaqueline Amati Mehler, che arrivò a considerarmi un vero caso clinico e mi classificò con lo pseudonimo X nel suo libro La babele dell’inconscio) durata otto anni, con l’incredibile frequenza di cinque sedute a settimana. Ne ero totalmente condizionato riguardo ai viaggi, al lavoro e alla vita tutta.
Parallelamente iniziai un lavoro profondo e costante sui blocchi strutturali e muscolari, con l’aiuto di un’esperta in tecniche corporee, Anna Maria Vitali, vero genio in materia. Anche il mio vissuto sentimentale era cambiato molto dopo la separazione da Lily e dalla famiglia, nel 1988, quando decisi di andare a vivere gran parte del mio tempo in una casa molto isolata in mezzo a un bosco nelle colline toscane (in una terra abitata, secoli addietro, da San Francesco, la cui presenza ancora vi aleggiava).
Inoltre nel ’93, dopo la fine della dittatura e il ritorno della democrazia in Uruguay, i miei genitori erano tornati a stare a Montevideo. Fu proprio in quella città, dov’ero andato per visitare i miei, e grazie all’insistenza di Sonia Wolf (figlia di Doris, la mia compagna delle elementari), che decisi d’iscrivermi a un corso intensivo nello Spazio di Sviluppo Armonico diretto da Graciela Figueroa, ballerina e terapeuta molto brava, che avevo conosciuto all’epoca del mio bazzicare i teatri a Montevideo.
L’incontro con Graciela, e soprattutto una sessione personalizzata con massaggio che lei volle offrirmi, fu per me un’esperienza trascendentale, che considero a tutt’oggi e a tutti gli effetti come una seconda nascita. Ma ora con licenza di vivere. Il rifugio in campagna mi attirava sempre più e vi trascorrevo una quantità sempre maggiore di tempo. Decisi quindi di andarvi ad abitare stabilmente, affittando a Roma un monolocale come punto d’appoggio.
Dopo aver vagabondato per tanto tempo nelle città degli uomini e sulle scene teatrali, dove tutto lotta per penetrare lo sguardo e catturare l’attenzione, trovarmi immerso in un mondo vegetale che semplicemente “esiste” fu per me una scoperta tanto grandiosa quanto tardiva e inaspettata. La fugace ed estemporanea apparizione di creature del bosco quali cinghiali, cervi, fagiani, volpi, porcospini e formichieri mi procurava attimi d’intense epifanie. Il sapore che variava a ogni stagione, la profondità sonora dello spazio, la densità materica del buio notturno e il cielo stellato erano rivelazioni intensissime per chi aveva cercato sempre e solo le pietre e il cemento.
Con la psicanalisi ero riuscito a scoprire in me il possibile, ma ora mi trovavo in cerca di un’altra via per ulteriori approfondimenti sulla mia psiche. E le strade nelle quali m’imbattevo erano percorsi esistenziali e di esperienze. Soltanto in quel momento potevo essere pronto ad affrontare quelle situazioni. Mi confrontai con una serie di tecniche fondamentalmente corporali: massaggi, yoga, “Rio Abierto”, Tai Ci. Sapevo che Peter Brook praticava un lavoro psicofisico tratto dagli insegnamenti di G.I. Gurdijeff, maestro sul quale (e del quale) avevo già letto molto, restandone assai colpito, negli anni lontani della mia formazione (letture intraprese dopo il mio incontro con lo strano libro Il ritorno degli stregoni, di Louis Pauwels e Jaques Bergier).
E avendo ammirato tanto, durante i nostri vent’anni di amicizia e sodalizio professionale, la capacità di presenza e di attenzione volontaria messa in atto da Brook, compresi che poteva esistere un rapporto fra le sue pratiche e i suoi talenti. Seppi allora formulare la domanda che fino a quel momento non ero riuscito a pormi, e scoprire che c’era un gruppo di lavoro proprio a Roma, vicino alla Stazione Termini; dopo poche settimane, ebbi il primo incontro di una lunga serie ancora non finita.
A questo gruppo di lavoro di autocoscienza, che reputo la mia vera casa (guidato con infinita saggezza da Mme Michèle Thomasson, che da Lione si reca ogni mese a Roma per dare risposte ai gruppi e trasmettere i movimenti), ho aggiunto un’integrazione con altre linee di ricerca della Quarta Via, in special modo quella conosciuta come SAT (“searchersafter truth”) che usa l’eneagramma, scoperto da Gurdijeff nello studio della personalità, e che è stata sviluppata ulteriormente dallo psichiatra e maestro spirituale cileno Dott. Claudio Naranjo (maestro a sua volta di Graciela Figueroa, colei che mi aveva fatto ri-nascere a Montevideo pochi anni prima).
Praticando questi sentieri di ricerca personale, conobbi un’insegnante di scuola elementare di Arezzo, Viviana Benci, della quale m’innamorai perdutamente (aveva venticinque anni meno di me, asimmetria alla quale avevo constatato di essere incline). Viviana mi propose di andare a vivere insieme a Camprione, la casa sulle colline toscane che avevo comprato qualche anno prima. Fu lei la prima persona giunta in quella specie di eremo disposta a restarvi da sola persino di notte, cosa che mi colpì moltissimo. Mi sentivo col cuore aperto a tutto e per niente al mondo sarei stato disposto a chiuderlo davanti a un imprevisto.
Fu così che decisi di mettere fine all’agenzia di Roma (risoluzione che non fu affatto semplice) e di staccarmi dal gruppo di persone con le quali collaboravo, fra cui mia figlia Mara; anni prima aveva lavorato a lungo con me anche Aldo Grompone, figlio di Lily. L’essere riuscito a trasmettere loro la mia professione “inventata” è fonte di soddisfazione enorme per me, forse in assoluto la più grande.
Non mi fu facile, in principio, abituarmi all’intensità della convivenza in campagna con Viviana, dopo oltre dieci anni di vita da single. Piantammo un orto e prendemmo con noi alcuni animali: due cani, ovvero il pastore maremmano Li e il dalmata Luki, e un gatto, il persiano Glauco, portato da Montevideo. Quando Viviana cominciò a manifestare il suo desiderio di maternità, mi sembrò più che naturale, in armonia col nostro progetto e il nostro percorso esistenziale, “imbarcare” un bambino sulla nostra nave, peraltro accogliente e spaziosa.
Nostro figlio René (da René Duval, l’autore di Monte analogo) e mio nipote Leone, figlio di mia figlia Mara, presero a viaggiare insieme alla volta del pianeta Terra, avendo solo mezzo anno di differenza l’uno dall’altro. Il 21 settembre del 2001 (dieci giorni dopo il crollo delle Torri Gemelle), all’ospedale San Donato di Arezzo, nacque René. Mio figlio non venne né circonciso, come avrebbe richiesto la religione del babbo, né battezzato, secondo quella della mamma. Intanto avevo perso mia madre nel giugno del 2000 e mio padre nel settembre del 2003, e presto avrei perduto anche la relazione con Viviana, la quale si era avviata lungo un implacabile percorso di allontanamento dalla nostra “nave”, portando con sé René: la nostra piccola famiglia da poco costruita si dissolse.
Nel 2005 decisi di vendere a un banchiere inglese “la nave”: era stata l’unica casa che avevo posseduto in tutta la mia vita (comprata nel 1990 con l’eredità dello zio Maier, fratello di mia madre, ricco commerciante di New York). Feci ritorno a Roma, la città in cui abita Mara con la sua famiglia, ma mantenendo una base in campagna vicino ad Anghiari, nei pressi di Arezzo. Si tratta di un vecchio granaio ristrutturato, di nome Sasseto: oggi è la casa di Luki (Li era scomparso con discrezione qualche mese prima della nascita di René), mentre il gatto Glauco è stato accolto da Tamara Cangi, la collaboratrice domestica che da vent’anni si prende cura di me assistendomi nei miei soggiorni in collina. È a Sasseto che passo regolarmente del tempo prezioso assieme a René, il quale adesso vive con Viviana ad Arezzo, in un appartamento di via Pescaiolina comprato per lui. Nella dimora di Camprione sono stati celebrati tre eventi importanti: l’inaugurazione della casa, in coincidenza con i miei cinquant’anni, nell’estate del 1993; le nozze di Mara e Simone nel 1999; e l’addio alla casa nell’estate del 2005. La tenuta della Barbolana continua ad essere per me rifugio e focolare, essendovi stato “adottato” in tutti questi anni dai proprietari, che sono la famiglia di Marina Baldeschi.
Ho continuato il lavoro professionale, sebbene in modo ridotto e senza una struttura fissa, occupandomi dell’unico artista che ancora oggi mi fa vibrare: la coreografa Pina Bausch, creatrice del Tanztheater Wuppertal. È stata l’amica italiana di lunga data Leonetta Bentivoglio, giornalista e scrittrice, a farmi comprendere fin dagli anni Ottanta lo straordinario patrimonio espressivo del teatrodanza di Pina Bausch, oltre che a fungere da primo trait d’union tra me e questa maestra di danza e di vita.
Dispongo ora di tempo e disponibilità per poter offrire le mie competenze a vecchi amici, come l’artista colombiano residente a Barcellona Enrique Vargas, col suo magico Teatro dei sensi, e amici nuovi, come l’argentino Juan Carlos Corazza, maestro di attori residente a Madrid.
Sono convinto che l’indagine spirituale che mi assorbe attualmente sia la naturale continuazione, in forma diversa, di quella attuata dai maestri in campo teatrale ai quali mi sono dedicato professionalmente per trent’anni. Questa ricerca è stata il mio modo personale di sviluppare e mettere in pratica intuizioni già percepite durante i miei anni di formazione.
Fare il produttore di spettacoli fu il pretesto escogitato per giustificare la mia presenza in quella fucina di maghi e prestigiatori che è il teatro. In realtà mi sono sentito sempre un impostore, una spia, mentre adesso posso dichiarare apertamente le mie intenzioni di apprendista stregone, senza più pretesti. Ho scritto questa storia pensando soprattutto a René, che è ancora piccolo, e pensando al giorno in cui gli verrà chiesto chi era suo padre, e io non sarò più lì a raccontarglielo.
Perché ho scritto in spagnolo? Perché non sempre chi vuol parlare e chi desidera ascoltare parlano la stessa lingua. Ciò che conta è il desiderio di capirsi.
Somos viajeros del universo.
Cuando visitamos un sitio, nos reciben sus habitantes.
Nuestros padres por ejemplo.
Quedandonos en el sitio, nosotros nos volvemo los habitantes.
Y con el tiempo, seremos nosotros los que reciben nueva visita.
Nuestros hijos por ejemplo.
Luego llega el momento de emprender nuevamente el viaje.
A la llegada del visitante se le dice nacimiento.
A la partida del visitante se le dice muerte.
Siamo viaggiatori dell’universo.
Quando visitiamo un posto, i suoi abitanti ci accolgono.
I nostri genitori, per esempio.
Rimanendo in quel luogo diventiamo i suoi abitanti.
E col tempo siamo noi ad accogliere coloro che arrivano.
I nostri figli, per esempio.
Poi arriva il momento di riprendere il viaggio.
L’arrivo del viaggiatore è detto nascita.
La partenza del viaggiatore è detta morte.
Sasseto, Anghiari
Dicembre 2006 – Marzo 2007
Andres Neumann ha pubblicato la sua Autobiografia.
Se siete curiosi, potete leggerla su qualsiasi dispositivo o su stampa, in 5 lingue.
RICAPITOLAZIONE
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.